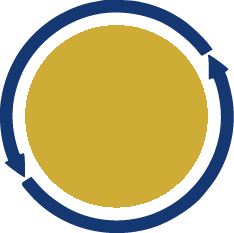di Gian Antonio Stella
Insulti e oltraggi: una guida di Tullio De Mauro lungo l’itinerario dell’odio. Alla Camera il testo, preparato per la Commissione «Jo Cox» presieduta da Laura Boldrini
«Bietolone buffone cialtrone/ beduino budino levantino/ vacca zambracca patacca/ crucco calmucco babbalucco». Fosse ancora dei nostri, Luigi Meneghello potrebbe trovare mille spunti preziosi e divertenti per le sue stralunate filastrocche in quella che probabilmente è l’ultima opera alla quale mise mano, prima di andarsene, Tullio De Mauro.
Si intitola Parole per ferire ed è un campionario di insulti preparato per la «Commissione sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio» presieduta da Laura Boldrini e dedicata alla deputata inglese Jo Cox, contraria alla Brexit e assassinata prima del referendum britannico da un neonazista. Non un noioso elenco di offese e parolacce, ovvio. Ma una guida ragionata, dentro una relazione che sarà presentata il 20 luglio alla Camera e anticipata in parte mesi fa da «Internazionale», lungo l’itinerario dell’odio. Itinerario più complesso di quanto sia immaginabile.
Imbecille, idiota o cretino, infatti, sono pugni in faccia identificabili all’istante come insulti. Ma «può accadere che qualsiasi parola e frase del tutto neutra in sé», spiega il grande linguista napoletano scomparso a gennaio, «in circostanze molto particolari possa essere adoperata per ferire». Cita ad esempio un libro del 1942 di Clive S. Lewis, Le lettere di Berlicche, dove un vecchio demonio, «sua potente Abissale Sublimità il Sottosegretario Berlicche», consiglia il nipote Malacoda, diavolo apprendista, su come seminare odio e rancore.
In particolare, ricorda De Mauro, lo istruisce sugli «ottimi effetti sulla via della dannazione che i tentatori possono ricavare dal far dire a qualcuno, specie in famiglia, frasi di apparente assoluta innocenza che però feriscono gravemente e vogliono ferire chi le ascolta (il coniuge, un parente stretto): “Brava, hai preparato il tè” (ossia: cretina, sei la solita peciona, sono le sette, renditi conto, stupida, che ormai è quasi ora di cena e per il tè siamo in ritardo di due ore). Risentimento della peciona, controrisentimento del marito che si appella all’innocenza della frase, eccellente astioso litigio sul nulla o quasi e preziosa fonte di odio».
Altro esempio? «Nell’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht in una scena madre la signora di aspirazioni aristocratiche insulta Jenny Diver, una prostituta, gridandole: “Puttana!” E Jenny con calma le risponde con uno sferzante “Signora!” Ma già Dickens si era divertito a osservare quanto a volte potesse essere ingiurioso l’uso allocutivo, vocativo, di Mister, Signore».
Insomma, alla voce hate words, parole d’odio, non ci sono solo i «termini odiosi che provocano dolore perché sono dispregiativi per natura». Quelli «peggiori che si possano usare, soprattutto se si appartiene a un gruppo che esercita il potere su un altro perché costituisce una minoranza o perché ha alle spalle una lunga storia di discriminazione» come spiega Aaron Peckham, l’autore dell’Urban Dictionary dedicato ai neologismi e allo slang in lingua inglese. Non esistono soltanto «gli insulti volgari, le male parole, in genere legate a materie escrementizie e attività sessuali tabuate» o le «designazioni insultanti di categorie deboli o tali ritenute», sostiene Tullio De Mauro.
Esiste anche, spiega, «una vasta categoria di parole che non sono in sé volgari insulti né sono parole riconducibili a stereotipi etnici e sociali. Si stenterebbe a rintracciare volgarità o stereotipi discriminatori in parole come bietolone, bonzo, lucciola, parrucchiere che tuttavia in italiano sono usate anche come insulti efficaci». Prendete «pecoraio»: in sé è un mestiere come un altro di antica nobiltà, eppure viene scagliato addosso come un sinonimo di «ignorante». «Uno stereotipo particolarmente falso», scrive il linguista: «Nell’Italia preunitaria, sepolta nell’analfabetismo, proprio i pecorai, spostandosi nelle transumanze e leggendo nelle soste a compagni ignoranti i “libri de pelliccia”, i grandi poemi cavallereschi che portavano con sé nelle tasche delle pellicce, furono agenti di promozione di italianità linguistica».
Lunghissimo l’elenco, dialetti compresi, degli insulti agli omosessuali, da bagascione a baldraccone, da buliccio a garruso, da invertito a tubo. Sconfinata la lista degli oltraggi alle donne. Con varianti così eccentriche da risultare spesso ignote. O quasi: da baiadera ad androcchia, da cunnivendola (copyright di Giorgio Manganelli) a ditteride («derivato da ditterio “mercato”, usato da Carlo Dossi»), da horizontale («francesismo usato da G. D’Annunzio, adattato in orizzontale da Ferdinando Martini») a nottivaga, da quadrantaria fino alla sbalorditiva «sgonnnellatrice».
Su tutti, però, svettano gli insulti etnici: «albionico “britannico” “perfido”; americanata “grossolanità vistosa e superficiale”; ascaro “seguace di basso rango”; baluba lomb. “persona rozza e incivile”; barbaro (una sorta di iperonimo generalissimo, ereditato dalle lingue classiche), “rozzo, incolto”, ma anche “feroce, crudele, efferato”; beduino “incivile”; calmucco “persona goffa o imbacuccata in modo ridicolo”». O ancora «crucco, dal serbocroato kruh “pane”, nomignolo dato da soldati italiani prima (1939) ai militari altoatesini e trentini, poi (1942) anche agli slavi meridionali, infine generalmente ai tedeschi». Fino a «marocco», «maumau», «zulù». Il nome d’un gruppo etnico africano del tutto privo in sé di valenze negative, ma usato come uno schizzo di letame contro tutti i neri.
Ecco il punto: «Le parole non sono simboli di un’algebra astratta», spiegò tre anni fa De Mauro in un’intervista all’Associazione Carta di Roma, «Non ci servono solo a indicare cose e azioni, ma anche segnalano, magari senza che ce ne rendiamo conto, chi siamo noi che le adoperiamo e come ci collochiamo verso ciò di cui parliamo. Questo vale sempre, vale tanto più quando la parola, scritta o trasmessa, è destinata a un vasto pubblico». Ciò che trasmettiamo allora «andrebbe sempre letto con gli occhi dei destinatari, specialmente con gli occhi delle persone di cui parliamo». I razzisti sanno farlo benissimo: ogni parola è una pugnalata. Gli antirazzisti no. Non sempre.
La conclusione del grande linguista al catalogo (che «può essere forse istruttivo ma a tratti è ripugnante»), è nella citazione iniziale di una straordinaria poesia di Gianni Rodari cantata da Sergio Endrigo: « Abbiamo parole per vendere,/ parole per comprare,/ parole per fare parole./ Andiamo a cercare insieme/ le parole per pensare./ Abbiamo parole per fingere,/ parole per ferire,/ parole per fare il solletico./ Andiamo a cercare insieme/ le parole per amare».